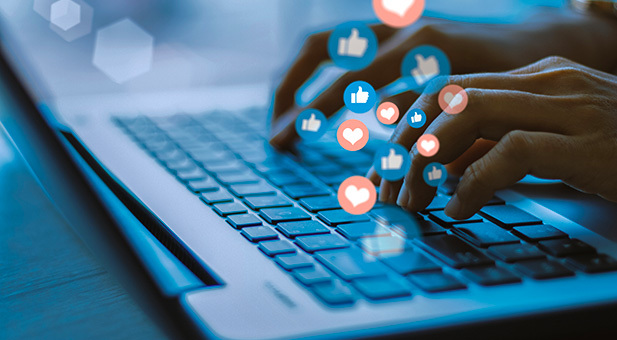Quanto conta il valore del brand
Tra tecnologia, velocità, globalizzazione, nuovi sistemi valoriali, raggiungere il consumatore è impresa sempre più complessa per chi investe in comunicazione e per chi la produce. L’evidenza di una difficoltà crescente nel parlare con il pubblico, Upa, associazione degli investitori pubblicitari, e School of Management del Politecnico di Milano, hanno avviato Branding e-volution, un progetto di ricerca finalizzato a fornire uno scenario del mercato italiano e un contributo di analisi a supporto degli operatori del settore, inserzionisti e pubblicitari.
Il progetto è stato concepito oltre un anno fa, e nel frattempo, come ha ricordato il presidente di Upa Lorenzo Sassoli de Bianchi, “alcuni trend si sono accelerati, altri fermati, in una fase di complessiva turbolenza nella quale non sono ancora stati raggiunti i livelli di investimento pubblicitario precedenti alla crisi dal 2008”. Gli ultimi anni hanno visto lo sviluppo di nuove forme di comunicazione, con metodologie e obiettivi diversi, prima fra tutti l’influenza del digitale. E in questo contesto di crisi economica correlata al Covid, Sassoli de Bianchi ha voluto portare un elemento di ottimismo, ricordando che a giugno Upa aveva stimato una chiusura 2020 del mercato degli investimenti pubblicitari a -17%, mentre i risultati di oggi offrono una previsione a -12%, migliore rispetto al -13% registrato nel 2013, l’annus horribilis post crisi.
Il progetto Branding e-volution trova la sua origine, secondo le parole di Giuliano Noci, ordinario di Marketing e Prorettore delegato del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, nella volontà di misurare una percezione vissuta, cioè che la comunità del marketing sia, rispetto alle campagne di comunicazione, eccessivamente concentrata sugli indicatori e sulle prestazioni di breve periodo, una “sensazione” che trova conferma anche in ricerche internazionali.
C’è una sorta di scollamento tra l’urgenza dell’oggi e la necessità di creare per il brand delle basi di evoluzione e radicamento che necessitano di un periodo medio-lungo, una situazione che per Noci “trova origine in due determinanti: la prima correlata all’affermazione delle tecnologie digitali che, per la novità e perché più facilmente misurabili, hanno portato l’enfasi sui risultati immediati delle azioni, la seconda riguarda la complessa realtà che la comunità manageriale si trova ad affrontare”. Il cambiamento ha molteplici volti ma si può descrivere nel passaggio da una situazione in cui, fino a pochi anni fa, la marca era correlata principalmente allo storytelling, al momento odierno in cui il brand diventa anche sistema “in un contesto in cui i touch point interagiscono inevitabilmente e la marca non è più solo trasposizione di posizionamento ma anche qualità di customer experience”.
La performance sacrifica il valore della marca
La ricerca – presentata da Nicola Spiller, School of Management del Politecnico di Milano e Alberto Vivaldelli, Responsabile Digital Upa - ha reso evidente la modalità verso cui sta evolvendo il mondo della comunicazione sulla scia di Millenial e Generazione Z, consumatori che tendono a mantenere una propria opinione e a “fare richieste” alla marca. Gli advertiser percepiscono un cambiamento nel rapporto con il pubblico, che apparentemente “dà per acquisito” il valore funzionale dei prodotti e chiede qualcosa in più a livello di emozioni, con l’esito di mettere sempre in discussione la relazione con la marca. È così che le imprese si ritrovano – nel modello di un uso sociale del brand – a rincorrere gli stimoli che pervengono dai propri consumatori, una modalità in antitesi con la situazione che vede il brand proporre dei valori sui quali chiede l’adesione del proprio pubblico. In relazione a questo maggiore coinvolgimento dell’utenza, si assiste ad un riposizionamento anche delle marche B2B verso logiche di B2B2C, che includono l’attenzione verso il cliente finale.
È questo un approccio che sembra guidare, almeno in parte, una sorta di operatività a sguardo corto, incentrata più sul risultato immediato che sulla prospettiva di consolidamento della relazione con il pubblico. E la seconda parte della ricerca, incentrata sul mercato degli investimenti pubblicitari, ha confermato questa impressione, mettendo però a confronto la percezione degli inserzionisti con quella dei player della comunicazione. La domanda su come è cambiato negli ultimi tre anni il bilanciamento tra investimenti per la sales activation (breve periodo) e il brand building (lungo periodo) ha messo in evidenza due punti di vista differenti tra advertiser e player della comunicazione: tra i primi il 43% ha dichiarato un aumento del breve periodo, il 25% un aumento del lungo periodo e il 32% ritiene il bilanciamento invariato; tra i secondi la percentuale di coloro che hanno colto un aumento degli investimenti per la sales activation è pari al 70%, il 13% coglie un aumento degli investimenti per il brand building e per il 17% la situazione è pari a tre anni fa.
Il confronto sui mezzi mette in evidenza una preferenza delle campagne digitali quando l’obiettivo è attivare le vendite, ottenendo performance di mercato sul breve periodo; viceversa per la costruzione del brand le imprese si affidano ai mezzi tradizionali, a partire dalle sponsorizzazioni fino all’editoria: lo spazio per quest’ultimo segmento non è da sottovalutare per la capacità di associare il marchio dell’inserzionista ad un contesto di contenuti di qualità, e il potenziale di crescita del settore è da ricercarsi in particolare nella capacità di profilare gli utenti e offrire informazioni di mercato utili agli advertiser.
Il digitale chiede canoni dedicati
Che il canale digitale sia un’esperienza diversa da quelli tradizionali, è emerso dalla ricerca presentata da Andrea Giovenali, ceo e founder di Nextplora, uno studio realizzato per capire il riscontro e l’effetto del digital branding sul pubblico. Il risultato dimostra come l’interazione, che è tipica dello strumento digitale, si trasformi in una maggiore vicinanza tra consumatore e brand, con i pro e i contro che ne conseguono, perché l’esperienza positiva sarà percepita come maggiorata, ma allo stesso modo la negativa avrà un impatto più forte. Una delle conseguenze di questa percezione amplificata è che il digitale richiede lo sviluppo di azioni di branding specifiche, che non siano la trasposizione online di messaggi studiati per la tv o la carta. Le aziende sono invitate a sviluppare azioni più ampie di coinvolgimento sul brand e di concreta vicinanza agli utenti del web che nella navigazione incrociano il messaggio, senza dimenticare che si tratta di un canale che non può essere esclusivo e va comunque integrato nell’ecosistema complessivo della comunicazione aziendale. Un aspetto su cui le imprese dovranno fare una riflessione riguarda il cambiamento che c’è stato nell’utilizzo del digitale durante il periodo di lockdown, e che lascerà il segno in termini di pervasività e di una maggiore coincidenza tra vita e attività online.
Non cambia la valenza della marca
E sul punto di come la distanza sociale della pandemia abbia cambiato il comportamento dei consumatori è tornato Federico Capeci, Ceo Italy, Greece & Israel, Insights Division di Kantar, identificando cinque trend emersi nel corso di un’analisi su un campione internazionale di pubblico. Si tratta di una mutazione sul rilievo che le persone attribuiscono oggi ad alcuni aspetti della vita, a partire dal significato dei valori, che avranno un peso maggiore nelle scelte che veramente contano. La sostenibilità non è più un progetto ma è un vissuto quotidiano, la ricerca di un equilibrio che è molto vicino alla concretizzazione dei valori individuali. Un diverso rapporto con il consumo, associato alla sensazione di precarietà e alle difficoltà economiche, potrebbero produrre un comportamento verso l’acquisto che metterà in primo piano la convenienza, ma con “puntate” compensatorie d’impulso verso beni di non immediato bisogno o di prezzo più elevato. Gli ultimi due punti riguardano l’aspetto più privato e il sociale, con la casa che diventa vero luogo di vita, laboratorio e centro della socialità, così come aumenterà il valore della condivisione, in gruppi più contenuti e attenti alla prossimità.
Anche in un contesto valoriale modificato, la marca continuerà ad avere il suo peso nell’influenzare il pubblico. Il tema torna ad essere quello dell’equilibrio tra performance e brand equity. L’intervento di Capece conferma che le imprese negli ultimi quattro anni si sono orientate prevalentemente verso strategie a performance, sostenute da modelli econometrici “sbagliati perché focalizzati sul breve termine”. Si sono invece ridotti gli investimenti in azioni di brand building, con un danno potenziale alla brand equity che rappresenta invece il capitale da coltivare in prospettiva, riconosciuto per il suo contributo nella riduzione della sensibilità al prezzo da parte del cliente, di creazione di valore per il futuro e di aumento della percezione di qualità.